
Decostruire dalla periferia: Abdulrazak Gurnah
Premiato con il Nobel per la letteratura nel 2021, Abdulrazak Gurnah nei suoi romanzi ha affrontato il tema del post colonialismo con gli occhi di chi, in prima persona, ha vissuto la condizione di rifugiato, di chi può parlare del centro pur essendo in periferia
di Matteo Proietti, Naomi Di Roberto, Ilaria Barricella
Decostruire e sradicare: è questo che fa Abdulrazak Gurnah quando scrive i suoi romanzi. Premiato con il Nobel per la letteratura 2021 “per il suo approfondimento appassionato e senza compromessi sugli effetti del colonialismo e sul destino dei rifugiati al confine fra le culture e i continenti”, Gurnah fornisce un’analisi di un tema, quello del post colonialismo, quanto mai moderna e introspettiva. Di origine africana, Gurnah si trasferisce nel Regno unito nel 1968 all’età di vent’anni, scelta che incide profondamente tanto nella scrittura quando nell’ideologia dei romanzi che verranno. Pur provenendo dallo stato della Tanzania, infatti, Gurnah non ha mai adottato lo swahili per scrivere i suoi romanzi, ma ha da sempre preferito l’inglese. La scelta compiuta dallo scrittore africano muove, come vedremo in seguito, dalla precisa esigenza di voler compiere un vero e proprio sradicamento della figura del rifugiato, vero filo rosso che ritorna in tutte le sue opere.
Gurnah non è solo autore di romanzi. Fino al 1980 è stato docente universitario alla Bakero University, in Nigeria. Consegue il dottorato di ricerca nel 1985 all’università del Kent, ambiente nel quale continuerà a svolgere il ruolo di docente di letteratura inglese e postcoloniale fino al recente pensionamento. Se la fortuna come docente è stata prematura, diverso è stato il suo destino per le prime opere pubblicate.
Il primo romanzo risale infatti al 1987, quando viene alla luce Memory of Departure, opera in cui l’autore tratteggia la figura di un giovane che, in cerca di fortuna, si allontana dalla costa per trasferirsi a Nairobi. Se il primo lavoro di Gurnah non ottiene il successo che forse si augurava, la svolta a livello mediatico arriva nel 1994 con la pubblicazione del suo quarto romanzo, Paradise. La trama ruota intorno al personaggio di Yusuf, giovane tanzaniano che, venduto a un mercante arabo, finisce per esplorare i contrasti vivissimi di culture diverse e amori contrastanti in un Congo alla vigilia della Prima guerra mondiale e della leva forzata che l’esercito tedesco impose alla popolazione locale. Ciò che emerge da questo romanzo, così come dai successivi, è il rifiuto della semplificazione della figura che gli occidentali hanno del Congo e dell’Africa stessa, mediante una lotta ai preconcetti e una sradicazione della figura del rifugiato che può essere sintetizzata con un termine: decostruzione.
Coniato dal filosofo francese Jacques Derrida, il termine decostruzione indica nel linguaggio filosofico il riconoscere la struttura originaria che soggiace alle singole manifestazioni storiche. Un riconoscere che è un de-costruire, una costruzione che si fonda sulla distruzione – la Destruktion heideggeriana – delle categorie metafisiche.
Questo processo di de-costruzione è presente, a più livelli, all’interno di ogni romanzo di Gurnah, divenendo così un vero proprio filo rosso della sua narrazione. Si spiega così la descrizione alternativa del paesaggio del Congo realizzata in Paradise, descrizione che sfugge a categorizzazioni univoche e che restituisce il paesaggio africano privo del filtro della visione occidentale. Il modello decostruttivo, tuttavia, non si applica soltanto ai paesaggi descritti; infatti, successivamente si fa strada una decostruzione che riguarda i soggetti tratteggiati nelle singole opere. Come in Desertion, romanzo del 2005, nel quale viene descritta una storia d’amore che sfugge ai cliché del colonial romance ma all’interno della quale vi è l’affermazione dei due protagonisti come individui, affermazione del sé che sfugge a qualunque possibile categorizzazione eurocentrica.
Ci si potrebbe chiedere, legittimamente, che cosa distingue i romanzi di Gurnah da altri dello stesso tipo, e perché mai ha ottenuto un riconoscimento così importante come il Nobel per la letteratura. Non si è infatti voluto premiare solamente la sua produzione, che oltre ai romanzi già citati presenta altri titoli di spessore come Admiring Silence (1996), By the Sea (2001), fino al più recente Afterlives (pubblicato nel 2020 ma iniziato a scrivere all’età di ventuno anni), ma anche un modo di scrivere che è un vero e proprio restituire l’identità e l’individualità ai soggetti descritti.
Per comprende a fondo la posizione di Gurnah, compiamo un passo indietro. Si è detto di come lo stesso scrittore, all’età di vent’anni, abbia provato sulla propria pelle la condizione di giungere in un paese, il Regno Unito, da rifugiato. Un rifugiato che scrive, e de-costruisce, la figura del rifugiato. È quello che Gayatri Chakravorty Spivak, filosofa e critica letteraria, si augura quando delinea il concetto di subalterno nella sua celebre opera Critica della Ragione Post Coloniale. Subalterna è una persona zittita, esclusa, privata della parola. Quella stessa parola che l’autrice di origine indiana restituisce ai subalterni compiendo quella de-costruzione di cui si è parlato in precedenza e realizzando quello che lei stessa definisce essenzialismo strategico: costruire identità, politiche e culturali, attraverso l’attribuzione di caratteristiche che siano proprie e uniche.
Più volte, nel corso dell’opera, Spivak ribadisce come sia impossibile dal centro parlare della periferia: è impossibile per lei, che vive a New York e insegna alla Columbia, parlare della “più povera donna del sud”, simbolo della subalternità. Ed è proprio qui, nello spazio che intercorre tra il centro e la periferia, che si incastra la figura di Abdulrazak Gurnah, che non soltanto compie la decostruzione del rifugiato, ma la compie partendo dalla periferia: Yusuf, Martin Pearce, Hassanali, in ciascuno di loro si nasconde un po’ di Gurnah ed è così che riescono a risolvere l’irrinunciabile e irrisolvibile paradosso dell’Io, un Io che si dispiega e si realizza tra le pieghe della decostruzione.
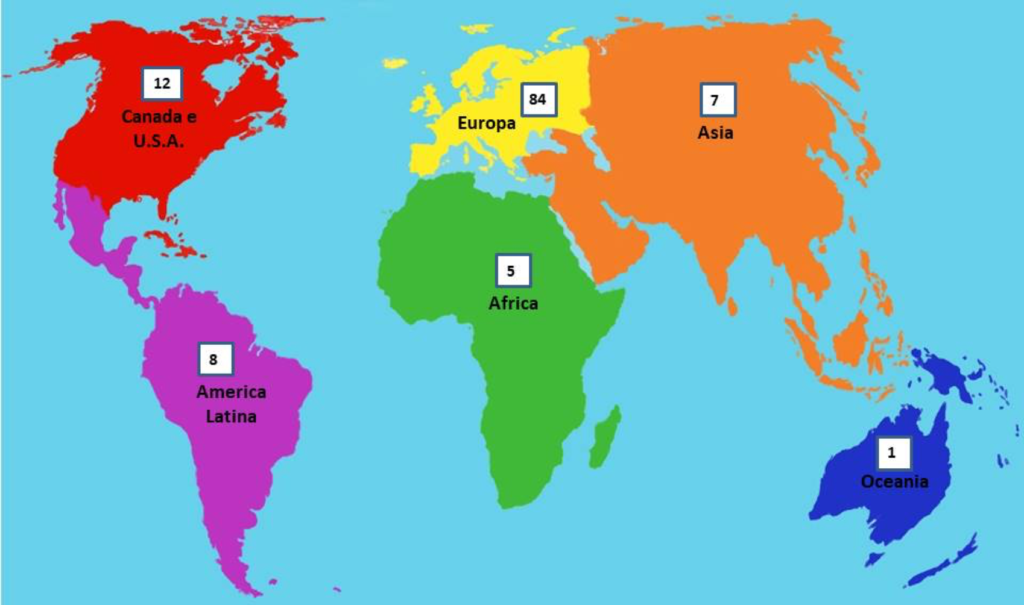
Giovanni Ruocco: il colonialismo tra passato e presente
Delle ragioni e dell’importanza dell’assegnazione del Premio Nobel per la letteratura ad Abdulrazak Gurnah e dei temi del colonialismo e delle migrazioni, cari allo scrittore, parliamo con Giovanni Ruocco, professore di Pensiero politico della colonizzazione e della decolonizzazione e Democrazia e critica delle società contemporanee all’Università Sapienza di Roma.
A oggi, quanto è utile parlare di post-colonialismo?
“Più che utile è un tema necessario. Se la nostra cultura eurocentrica è il prodotto di secoli, in particolare della costruzione storica e culturale realizzata tra Ottocento e Novecento, questa risente fortemente di un approccio coloniale, fondato sulla centralità del soggetto europeo e su una struttura epistemica alla base della pretesa superiorità dell’Occidente sul resto del mondo”.
Cosa significa aver insignito Gurnah del Premio Nobel?
“L’assegnazione di questo Premio Nobel è un evento importante, perché chiama in causa contemporaneamente tre temi: colonialismo, migrazioni e razzismo, focalizzando l’attenzione sulle modalità attraverso cui il colonialismo si è prodotto e tende a riprodursi ancora nelle nostre società e nelle nostre menti. Nel suo saggio La Doppia Assenza, il sociologo algerino Abdelmalek Sayad mette in continuità le modalità attuali di approccio alle migrazioni con quelle del colonialismo. Possiamo dire di non esserne ancora usciti anche per il modo in cui alcuni paesi occidentali continuano ad approcciarsi all’estrazione di risorse e all’utilizzo di spazi del mondo: una dimensione espansionistica e proprietaria, che tende a occupare i presunti spazi vuoti e ad appropriarsi di risorse non utilizzate, è tipica del colonialismo. Vale lo stesso per le modalità culturali e per le coordinate mentali che utilizziamo ancora oggi, figlie di quel passato coloniale e che si ritrovano nella prospettiva un po’ miope di trasformare l’idea di progresso nell’idea di sviluppo attuale”.
Come si è evoluto il tema del post-coloniale dalla metà degli anni ’50 fino a oggi?
“Se diamo un’accezione ampia al termine post-coloniale, questa ha seguito il corso delle decolonizzazioni, influenzando con forza una parte significativa della cultura occidentale, e non solo. Esiste poi una dimensione più specifica, che nasce soprattutto in ambiente letterario anglosassone intorno agli anni ’60 del secolo scorso, nella quale si è creato un movimento di trasformazione epistemica critica finalizzato a mettere in discussione l’approccio occidente-centrico nel modo di guardare il mondo. A lungo la voce dei popoli colonizzati è stata muta e assente. Ha iniziato a farsi sentire con forza a partire dal Novecento, e oggi si mescola a livello di nazionalità e contenuti. L’approccio post-coloniale critico riconsidera la geografia fisica e mentale tradizionale, superando le dicotomie centro-periferia, paesi colonizzatori-paesi colonizzati. Ciò non toglie che la storia continui a essere raccontata prevalentemente nello stesso modo o quasi, ed è ancora difficile vedere in tal senso una trasformazione consapevole e profonda. In Italia viviamo ancora il nostro passato coloniale come un elemento esogeno, quasi accidentale e di importanza limitata, non come parte integrante della nostra storia, perché questo passato è ancora molto difficile da affrontare e da assimilare”.
È presente, e in che misura, un senso di colpa collettivo?
“È difficile dirlo. Altri paesi meglio dell’Italia hanno acquisito l’idea di aver avuto un passato coloniale. L’Italia continua a dimenticarlo, a non renderlo parte della propria costruzione nazionale. Si prenda il caso della Germania che per anni ha resistito al proprio passato nazista: oggi, a Berlino, ci sono tante forme di memoria di quelle vicende. Il punto è questo: se rimane solo un senso di colpa non si va avanti, il cambiamento ci sarà nel momento in cui accetteremo tutti insieme l’eredità di quella stagione e tutti insieme ce ne faremo carico, così come ci dobbiamo fare carico delle persone che arrivano qui dalle migrazioni, spesso anch’esse eredità dei processi di colonizzazione. Bisogna saldare questo risarcimento del passato e andare avanti in modo finalmente consapevole non solo del passato, ma anche e soprattutto del presente”.
Crediti immagine in evidenza: Wikimedia commons















Commenti recenti