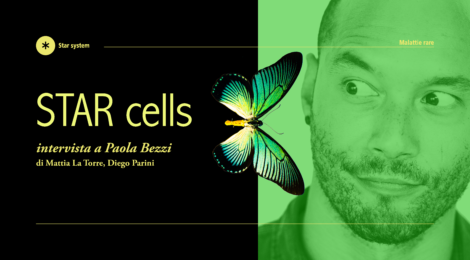
STAR cells
Il ruolo degli astrociti e dei neuroni nella malattia di DiGeorge. Le scoperte e le malattie rare. I pazienti e le associazioni. La migliore scienza e il contesto.
Intervista a Paola Bezzi
di Mattia La Torre e Diego Parini
Qual è la scoperta più emozionante della sua carriera?
Lo studio di certe proprietà di alcune cellule chiamate astrociti. Come dice la parola, queste cellule hanno la forma di una stella e si trovano intorno alle cellule nervose. La scoperta che abbiamo fatto è stata pubblicata su Nature nel 1998. Siamo stati tra i primi laboratori al mondo a scoprire che queste cellule, che fino ad allora non erano studiate, sono in grado di comunicare con i neuroni. Rilasciano sostanze che vanno ad interagire con alcuni recettori espressi sui neuroni, dando una serie di informazioni ai neuroni stessi. Abbiamo dimostrato la capacità di queste cellule di comunicare con il neurone, aprendo un nuovo campo di ricerca sugli astrociti. Prima di questa scoperta gli astrociti erano considerati come cellule poco importanti, poiché non si capiva bene qual era la loro funzione, addirittura lavori molto vecchi del 1950 pensavano che queste cellule fossero lì per supportare, e dare una struttura al neurone, essendo numerose e molte di più dei neuroni. La nostra domanda iniziale è stata: come è possibile che queste cellule svolgano solamente la funzione di supporto strutturale e non facciano nient’atro? Abbiamo così capito che queste cellule sono in grado di produrre e rilasciare tante diverse sostanze, come trasmettitori o sostanze trofiche dei neuroni, sostenendo il neurone in tutta la sua esistenza. Questa è la mia più grande scoperta e ha fatto sì che mi specializzassi su queste cellule a stella
Che ricadute ha avuto questa scoperta sulla sua attuale ricerca finanziata dal grant Telethon?
Moltissimi laboratori si sono messi a studiare la funzione degli astrociti: possono comunicare informazioni, aumentare o diminuire l’attività, oppure fornire sostanze trofiche al neurone. Negli ultimi dieci anni, mi sono focalizzata sul periodo post-natale nei topi, da subito dopo la nascita fino allo svezzamento. Abbiamo trovato che gli astrociti, anche in questa fase, sono importantissimi; infatti, dando delle tossine solo agli astrociti, il neurone smette di crescere. In sostanza togliendo l’astrocita, il neurone non cresce. Uno dei meccanismi che aiuta la formazione del neurone da parte dell’astrocita dipende dai mitocondri all’interno dell’astrocita, fondamentali per la produzione di energia per la cellula. Senza di loro, o con un loro malfunzionamento, la cellula non può produrre energia a sufficienza. Gli astrociti, in questa zona temporale, hanno moltissimi mitocondri, molti di più di quelli dei neuroni. Abbiamo scoperto che diminuendo la quantità di mitocondri, manipolandoli geneticamente, i circuiti nervosi non si sviluppano bene. Successivamente, ci siamo chiesti quale malattia del neurosviluppo abbia un’implicazione dei mitocondri. Molte malattie del neurosviluppo hanno dei problemi legati allo sviluppo dei circuiti nervosi, come ad esempio l’autismo o la schizofrenia, e presentano dei circuiti nervosi formati male perché si è avuto un problema subito dopo la nascita o durante la crescita. In letteratura abbiamo trovato la malattia chiamata di DiGeorge, o sindrome da delezione 22q11.2, in cui nel cromosoma 22 manca un pezzo di DNA. Ebbene, in quel pezzo di circa 30 geni, 8 sono geni che codificano proteine mitocondriali. Per questo, abbiamo pensato di studiare in dettaglio i mitocondri, se stanno bene o male; i risultati preliminari, utilizzati anche per applicare al Grant telethon, ci dicono che questi mitocondri non stanno bene.
È molto importante il rapporto con le associazioni dei pazienti?
Importantissimo, mi ha fatto venire tante idee e dato molti suggerimenti. Noi ricercatori siamo abituati ad andare nel dettaglio, ad esempio, voler capire perché i mitocondri degli astrociti siano così importanti, però alla fine parlando con i pazienti o i loro familiari, a loro del meccanismo non importa nulla. I familiari sono molto preparati, e le domande sono molto specifiche. Queste persone aspettano un’idea, una proposta che, anche se non cura completamente, magari migliora la situazione. Le persone mi han dato un sacco di idee. Mi hanno chiesto di fare qualcosa e io ho promesso di farlo.
Secondo lei quali sono gli ingredienti per ottenere i migliori risultati?
La collaborazione e lo scambio di idee. Spesso siamo un po’ intimoriti, ognuno di noi ha delle idee, ma finché non abbiamo dei risultati di cui siamo certi, non le diciamo, per paura di fare una figuraccia. Invece, forse, bisognerebbe avere il coraggio di aprirsi di più, ad esempio ai congressi, tra chi fa ricerca, soprattutto delle stesse o di simili malattie. Tuttavia, la scienza va testata e i dati devono essere riproducibili, spesso le idee originarie sono sbagliate e lo si capisce nel corso della ricerca. Questa paura di esprimersi può essere egoisticamente causata dal timore che altri ricercatori ci copino, questo però ai pazienti non interessa proprio nulla. Bisognerebbe cercare di aprirsi di più perché lo scambio è molto importante.
Il contesto, dentro e fuori il laboratorio, quanto è cruciale per la ricerca scientifica?
Più risorse si danno e più si ha la chance di trovare qualcosa di veramente importante. In generale la popolazione pensa che bisognerebbe dare più soldi a chi fa ricerche mirate su una patologia. In realtà, la maggior parte delle scoperte scientifiche, che hanno rivoluzionato la scienza e la tecnologia, sono state fatte non per uno scopo preciso e mirato, ma per caso. Un esempio è la scoperta delle proteine fluorescenti ritrovate nelle meduse. Senza queste proteine non potremmo fare la ricerca in vivo sui topi, perché ci permettono di vedere quello che c’è all’interno della cellula. Tuttavia, questa ricerca non ha ricevuto fondi per moltissimi anni, perché si credeva che fosse inutile studiare le proteine fluorescenti delle meduse. Ricerche che apparentemente non servivano a nulla, negli anni hanno avuto delle applicazioni incredibili. Le infrastrutture e i fondi sono basilari per la ricerca, perché altrimenti non si può lavorare. Questi soldi, tuttavia, servono sia per migliorare le strutture e gli strumenti, ma anche per pagare chi fa ricerca, perché devono essere pagati.
Secondo lei esiste un giusto equilibrio tra il numero di articoli da pubblicare e la qualità?
Sicuramente, per fare il salto di carriera ci vuole una buona pubblicazione nel proprio curriculum. Una buona pubblicazione è un articolo pubblicato su una rivista di alta qualità, però vuole anche dire realizzare uno studio molto complesso che richiede anni, da 3 a 5. Servono nervi saldi, estremo sacrificio, perché se bisogna finire i dati, si resta fino a tardi la sera e si lavora il fine settimana, serve molta diplomazia, perché spesso si collabora con altre persone. Se volete fare questo tipo di carriera almeno un lavoro di questa qualità bisogna farlo. Bisogna essere anche fortunati che la propria idea sia giusta, ma bisogna essere intelligenti per capire che se l’idea è sbagliata va cambiata in corso d’opera, perché non hai molti anni durante il tuo PhD. Ad ogni tappa della carriera bisogna fare un lavoro importante, perché aiuta a scegliere il laboratorio dove lavorare e, se hai lavorato bene, ti prenderanno in laboratori importanti.
Perché è importante studiare le malattie rare?
Proprio perché sono rare. Già non abbiamo farmaci per le malattie “comuni”, figuriamoci per le malattie rare. Qualcuno deve studiarle, perché non solo si aiutano i bambini, almeno per dargli qualche sollievo, ma benché siano rare spesso si possono capire dei meccanismi che potrebbero essere applicati ad altre malattie. Non è detto che ogni sintomo e ogni meccanismo sia specifico. Per esempio, il lavoro sui mitocondri è già applicato in molte malattie rare.
Un consiglio per i giovani ricercatori?
Non mollare, soprattutto non lasciarsi scoraggiare. Bisogna prefiggersi un obiettivo e questo obiettivo deve essere molto alto, l’obiettivo devono essere le stelle, perché a mirare in basso c’è sempre tempo.
Paola Bezzi, Farmacologa presso il Dipartimento di Neuroscienze fondamentali dell’Università di Losanna
per saperne di più:
La malattia di DiGeorge (conosciuta anche come sindrome da delezione 22q11.2) è caratterizzata dalla perdita, o delezione, di un pezzo del cromosoma 22. Viene considerata malattia rara, ma non rarissima poiché la sua incidenza è di 1 caso ogni 4000. Alcuni bambini presentano sintomi molto gravi, altri al contrario possono non averli gravi o svilupparli crescendo. La malattia viene diagnosticata principalmente per il presentarsi di problemi cardiovascolari. Intorno ai dieci anni di età si iniziano a sviluppare i sintomi, molto simili alla schizofrenia come: sentire voci, ansia e poca socializzazione. Se la malattia non viene diagnostica alla nascita con l’analisi citogenetica, il presentarsi di questi sintomi fa pensare a problemi di tipo psicologico, procedendo con cure psichiatriche. Sviluppandosi in tenera età, a differenza della schizofrenia, non esistono veri farmaci per trattarla. L’idea, sempre se viene diagnosticata in anticipo, è quella di trovare un modo per prevenire il sopraggiungere dei problemi. Un’ipotesi è quella di agire direttamente sui mitocondri degli astrociti, così da migliorare lo sviluppo dei circuiti nervosi dei bambini nel periodo post-natale. Quindi: prevenire i disturbi cognitivi curando direttamente i mitocondri. Una seconda ipotesi, oltre alla terapia genica, riguarda l’alimentazione. Si sta valutando sul modello murino se posticipando la data dello svezzamento, e fornendo una dieta chetogenica, si aumenta la produzione dei mitocondri. Questa potrebbe essere una terapia fattibile e, soprattutto, non invasiva per i bambini.
Guarda l’intervista completa sul canale YouTube di STAR

















Commenti recenti